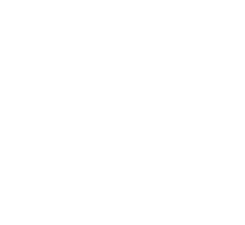Lo stimolo della sete
Il meccanismo della sete viene attivato soprattutto da un’aumentata concentrazione del plasma nell’organismo, che può avvenire sia per una perdita d’acqua che per aumento dei soluti con conseguente disidratazione cellulare, e dalla diminuzione del volume del sangue circolante, che a sua volta comporta un abbassamento della pressione arteriosa. Si tratta di un meccanismo estremamente complesso e sensibile che raccoglie ed elabora vari segnali provenienti da diversi tipi di recettori localizzati in più parti del corpo che agiscono, sia inducendo il bisogno di bere, che limitando la quantità di acqua eliminata attraverso le urine. Al contrario, in caso di innalzamento della pressione arteriosa e del volume del sangue, viene indotta la perdita di acqua (e sodio) attraverso i reni. Nella maggior parte delle persone sane lo stimolo della sete può essere utilizzato come guida per un’adeguata assunzione di fluidi e, quindi, per prevenire la disidratazione. Ciò non si può dire per alcune categorie come gli atleti e per chi è esposto ad alte temperature in quanto necessitano di assumere maggiori quantità di acqua, nonché per le persone non autosufficienti, gli anziani e i bambini, per via di una diminuzione della sensazione di sete o per l’incapacità di comunicarla. Bisogna poi considerare che anche nelle altre fasce di popolazione, fattori psicologici e sociali (ad esempio il consumo di bevande come momento di socializzazione) si sovrappongono ai normali meccanismi regolatori, il cui compito è quello di mantenere costantemente controllato il contenuto idrico del nostro organismo (che in genere non subisce variazioni superiori all’1% al giorno dell’acqua totale, neanche in condizioni di stress).
La disidratazione
Si tratta di uno stato patologico, corrispondente alla diminuzione dell’acqua corporea uguale o superiore all’1% del peso corporeo, che si instaura quando si ha un’insufficiente assunzione di liquidi oppure un aumento della loro perdita per via gastrointestinale, urinaria, cutanea o attraverso l’apparato respiratorio. Una lieve disidratazione cronica può essere presente in coloro che, per varie ragioni, non riescono a soddisfare le esigenze giornaliere di acqua. Tale stato è comune soprattutto negli anziani e in coloro che svolgono un’attività lavorativa che comporti un elevato impegno fisico in ambienti caldi. I primi sintomi di disidratazione sono mal di testa, perdita di appetito, arrossamento della pelle, intolleranza al calore, sensazione di secchezza della bocca e degli occhi, apatia, senso di affaticamento, crampi muscolari, per arrivare, in caso di disidratazione maggiore, a vertigini, nausea, vomito, diminuzione del livello di attenzione e di concentrazione, sdoppiamento della visione, fino alla perdita di coscenza.
Più livelli di disidratazione
È sufficiente una disidratazione del solo 1% del peso corporeo per avere ripercussioni sull’attività e sulle performance fisiche. Se la disidratazione sale al 2%, vengono alterati la termoregolazione e il volume plasmatico. Una disidratazione maggiore del 4% porta ad importanti cali della prestazione fisica, a difficoltà di concentrazione, mal di testa, irritabilità e sonnolenza, aumentando sia la temperatura corporea che la frequenza respiratoria. Una carenza di acqua che superi l’8%, infine, rappresenta un serio pericolo per la vita. L’iperidratazione, al contrario, consiste nell’aumento patologico del volume dei liquidi biologici che si verifica se l’assunzione di acqua supera la velocità massima di escrezione dei reni; tuttavia è una condizione molto rara negli adulti sani e con normali abitudini alimentari.
L’acqua come strumento di prevenzione
Una buona idratazione è un fattore di prevenzione e di terapia per svariate patologie come Calcolosi urinaria, Stipsi, Cistite e Iperglicemia, ma viene associata anche ad una riduzione dell’Ipertensione. D’altra parte il volume del sangue, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca sono strettamente collegati al fattore idratazione. Negli individui sani, leggeri cambiamenti della frequenza cardiaca e della vasocostrizione bilanciano l’effetto che le normali fluttuazioni del volume di sangue esercitano sulla pressione sanguigna. I reni, in questo senso, sono fondamentali nella regolazione dell’equilibrio dell’acqua e della pressione del sangue. Il loro meccanismo, infatti, è basato sull’equilibrio dei fluidi, ciò li rende più efficienti in presenza di acqua. Al contrario, in caso di scarso apporto idrico, i meccanismi deputati al recupero dell’acqua determinano uno stato di stress dell’organo renale. Per concludere, uno strumento utile per capire se lo stato di idratazione del nostro organismo è buono è l’Analisi dell’Impedenza Bioelettrica (BIA), studiata per valutare, grazie all’utilizzo di una dispositivo multifrequenza, il volume dei diversi componenti corporei.