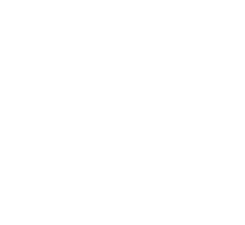L’effetto dipendenza
L’utilizzo cronico di caffeina, grazie alla già menzionata tolleranza, può indurre una dipendenza sia comportamentale (psicologica) che fisiologica. La prima si esprime con una ricerca continuativa dell’assunzione della sostanza, mentre la seconda è caratterizzata da segni e sintomi indotti dalla sospensione improvvisa di un utilizzo cronico. Entrambi questi fenomeni vanno comunque differenziati dal cosiddetto effetto “rimbalzo”, ovvero il significativo rilievo di un sintomo come la sonnolenza, che viene inibito dalla caffeina, a distanza di qualche ora dall’assunzione anche di una singola dose, cioè all’esaurirsi del suo effetto farmacologico in parallelo alla riduzione della concentrazione nel sangue del principio attivo. I sintomi da sospensione che evidenziano una dipendenza fisiologica sono numerosi, di questi, i più comuni sono sonnolenza e cefalea che possono presentarsi anche a 12-24 ore dall’astinenza di una assunzione giornaliera di 100 mg di caffeina, contenuti ad esempio in un caffè espresso, per 3-7 giorni.
Valutare le dosi
La maggiore difficoltà nello stabilire i livelli di assunzione di caffeina nella popolazione generale è dovuta al contenuto variabile di tale sostanza nei diversi alimenti o bevande di comune utilizzo, a partire dal caffè stesso, oltre che dalle differenti quantità con cui i vari prodotti sono generalmente serviti. Ad esempio un caffè espresso ne contiene mediamente 100 mg, un caffè “americano” supera i 250 mg, un caffè solubile dai 40 ai 110 mg, e infine un decaffeinato non raggiunge i 10 mg. Inoltre gli studi che “fotografano” una situazione epidemiologica non consentono di stabilire un nesso di causalità, ma evidenziano solo delle associazioni tra i fattori che rilevano come l’uso di caffeina, la qualità del sonno notturno e la sonnolenza diurna. Diversi studi hanno comunque cercato di attuare queste stime, con risultati diversi che vanno da una assunzione media di 4 mg/Kg, ovvero 280 mg per un uomo di 70 Kg, a 190 mg al giorno. Bisogna comunque rilevare che il rapporto tra un cattivo sonno notturno e l’utilizzo diurno di caffeina può essere bidirezionale, ovvero è possibile che si dorma peggio per aver bevuto “troppo” caffè, ma è ugualmente possibile che si assuma molta caffeina per cercare di “compensare” gli effetti di un cattivo sonno. Ne risulta quindi che entrambe le ipotesi possono essere vere e determinare un circolo vizioso. Nell’ambito della Medicina del Sonno si incontra spesso il problema di un sonno notturno non ristoratore o di una franca insonnia. In questi casi il Medico propone in prima battuta l’utilizzo di norme comportamentali di buona “igiene del sonno”, tra cui evitare attività e sostanze “risveglianti”, ivi inclusa ovviamente la caffeina, dal pomeriggio in poi per ridurre i fattori che influenzano negativamente il sonno o la capacità di addormentarsi. Sebbene questi consigli siano largamente condivisi e dettati dal “buon senso” comune, alcuni studi ne hanno valutato l’efficacia evidenziando che effettivamente la sospensione dell’assunzione di caffeina determina un sostanziale miglioramento del sintomo insonnia in chi ne è affetto.
Come dosare la caffeina
L’assunzione di caffeina deve essere presa in considerazione nella valutazione di problemi del sonno notturno e di sonnolenza diurna non solo negli adulti ma anche negli adolescenti (in quanto, come abbiamo detto, diverse bevande, farmaci e alimenti ne contengono quantitativi variabili). L’utilizzo protratto di caffeina e l’incapacità di interromperne l’assunzione può riflettere una vera e propria dipendenza. In questi casi è opportuno procedere ad una riduzione progressiva dell’assunzione fino alla completa sospensione seguendo i consigli del proprio Medico di riferimento.
L’interruzione, soprattutto se improvvisa, dell’utilizzo di caffeina è una potenziale causa o fattore contributivo nel determinare sonnolenza diurna. Molti degli effetti della caffeina non sono del tutto noti anche per la difficoltà di effettuare studi “puliti” su una sostanza di larghissimo consumo. In particolare non è stato ancora definitivamente dimostrato quali aspetti delle prestazioni diurne siano influenzati in senso positivo o negativo.