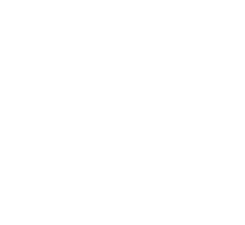Le piante per un pianeta che cambia
L’urgenza di disporre di piante che riescano a vivere e a produrre bene nei nuovi contesti colturali ha portato al recupero di varietà locali/antiche (ecotipi) ben adattate a crescere in condizioni difficili e fonte di caratteri utili, nonché alla costituzione de-novo di varietà con specifici tratti di resistenza/tolleranza a basse temperature, gelate, carenze di acqua, anossia, salinità del suolo, infezioni parassitarie (causate dall’invasione di insetti e organismi alieni portati nelle campagne dalla globalizzazione degli scambi commerciali, oltre che dalle variazioni del clima) e più ricche di sostanze nutritive.
Il miglioramento genetico è classicamente basato su cicli di incroci tra genitori che, singolarmente, possiedono i caratteri utili che si desidera siano presenti nella nuova varietà; la selezione nelle generazioni segreganti, infatti, consente di individuare le piante che ricombinano i caratteri positivi di entrambi i genitori. La selezione assistita da marcatori molecolari aiuta a fare uno screening precoce e accelera i tempi della selezione.
Le biotecnologie di seconda generazione hanno aperto nuove prospettive essendo in grado di modificare geni di caratteri utili senza l’inserimento di DNA estraneo.
Perdiamo le eccellenze nazionali?
Niente affatto. Infatti, se parliamo di sapori o caratteristiche di pregio presenti in determinate varietà antiche, Mendel insegna che un carattere, quindi anche un sapore, può essere trasferito da una varietà ad un’altra: quindi, se consumatori fidelizzati chiedono di riavere un determinato sapore “antico” si può fare una varietà moderna con il sapore antico. Esattamente come la Fiat 500 di oggi: una macchina moderna che ha conservato l’estetica e la carrozzeria del modello originario, però con motore elettrico o, comunque, un motore a minore consumo di carburante e minori emissioni di CO2.
Epigenetica: una nuova risorsa
Le stagioni di crescita, sempre meno prevedibili, spingono a valorizzare la capacità naturale delle piante di attivare o disattivare rapidamente determinati geni in risposta ad eventi di stress. Come appena visto, i Centri di ricerca utilizzano incroci e selezione per creare varietà moderne che possono prosperare in condizioni di crescita difficili. Spesso si adotta un compromesso tra l’obiettivo di sfruttare il massimo potenziale di resa e quello di garantire la sua stabilità in ambienti avversi. Per esempio, è possibile coltivare una varietà molto tollerante alla siccità, ma in un anno in cui non vi è alcuna siccità, questa varietà potrebbe produrre molto meno. Per raggiungere una stabilità di performance, ultimamente ci si è interessati al ruolo che meccanismi epigenetici (processi biologici che attivano o disattivano i geni) possono svolgere in questo equilibrio dinamico tra potenziale di resa e stabilità di resa. Se i coltivatori potessero migliorare la capacità delle piante “premendo un interruttore” quando le condizioni ambientali cambiano, questo consentirebbe, ad esempio, di attivare cambiamenti fisiologici che aumentano la tolleranza alla siccità solo quando necessario, evitando di interferire sulla produttività della pianta in ambienti ottimali. Come è noto, l’epigenetica studia come modificare le informazioni codificate da un gene senza cambiare la sequenza del DNA, ma alterando la trascrizione oppure la traduzione del messaggio contenuto nel gene medesimo.
I filoni di studio
Le ricerche attualmente sono indirizzate a identificare e caratterizzare i geni che controllano importanti caratteri di piante di interesse agricolo (principalmente, vite e melo) che sono epigeneticamente repressi da alcuni procedimenti chimici che hanno luogo sugli istoni (proteine che rivestono le eliche del DNA nel cromosoma) o sulla catena di DNA da minuscole molecole di RNA, in risposta a situazioni di stress (funghi, batteri, insetti) e condizioni ambientali negative (freddo e siccità).
Quindi, in alternativa all’uso di presidi chimici, viene proposto un nuovo tipo di prodotto fitosanitario basato sull’azione di piccoli RNA interferenti, questi interferiscono con l’espressione di specifici geni, degradando l’RNA messaggero (mRNA) dopo la trascrizione del DNA, in modo tale da non far avvenire la traduzione in proteina del messaggio contenuto nel gene medesimo.
I progressi tecnici raggiunti nell’uso di siRNA permettono la preparazione di formulati con ottime caratteristiche di efficacia, stabilità e persistenza nella pianta ospite: è realistico considerare, quindi, l’utilizzo di siRNA come “biopesticida” applicabile come spray fogliare, concia dei semi o direttamente nel suolo, con elevata specificità e biosicurezza rispetto ad alcuni prodotti chimici o strategie alternative di biocontrollo.