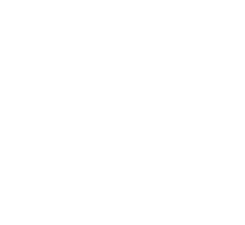Il percorso di diagnosi
Il processo diagnostico della Celiachia comprende la valutazione della storia clinica e dei sintomi, l’esecuzione di test sierologici e di una gastroscopia con biopsie duodenali.
Anche in assenza di sintomi clinici, lo screening per la Malattia celiaca deve essere valutato nei parenti di primo grado di Pazienti celiaci e nei Pazienti con Diabete mellito di tipo 1 e Sindrome di Down, data l’alta prevalenza in questi gruppi.
Nel siero dei Pazienti affetti da Celiachia possono essere individuati specifici anticorpi:
- anticorpi anti-transglutaminasi (TGA) di tipo IgA ed IgG: sono raccomandati come primo test di screening; mostrano una specificità e una sensibilità intorno al 95%;
- anticorpi anti-endomisio (EMA) di tipo IgA: mostrano un’alta specificità (intorno al 99%) e possono essere utilizzati in caso di diagnosi incerta nelle popolazioni a rischio;
- peptide della gliadina deamidata (DPG) di tipo IgA e IgG: mostrano una specificità e una sensibilità intorno all’80% e sono utilizzati in combinazione agli anticorpi TGA IgA nella popolazione pediatrica (bambini al di sotto dei 2 anni di età).
La gastroscopia con esecuzione di biopsie duodenali è considerata componente cruciale della valutazione diagnostica nel sospetto di Malattia celiaca. È necessaria l’esecuzione di biopsie duodenali multiple per dimostrare le lesioni tipiche della malattia (atrofia della mucosa con iperplasia delle cripte).
La diagnosi di Malattia celiaca non è sempre lineare: le Linee Guida internazionali suggeriscono alcune possibili strategie per raggiungere una diagnosi corretta in particolari casi. La prima raccomandazione è, ad esempio, quella di escludere la presenza di deficit di IgA. Nei Pazienti con sierologia negativa è necessario escludere la presenza di altre possibili cause di atrofia dei villi intestinali quali l’Immunodeficienza comune variabile, Patologie autoimmuni ed infiammatorie croniche, l’uso farmaci e la presenza di neoplasie. Si raccomanda di valutare la sierologia e l’istologia duodenale mentre il Paziente sta ancora seguendo una dieta contenente glutine.
Test genetici
L’esecuzione dei test genetici serve soprattutto a escludere la diagnosi; nel caso in cui il Paziente non sia portatore dei geni coinvolti (HLA DQ2/DQ8), infatti, si può escludere la presenza della malattia. La presenza dei geni, invece, essendo riscontrabile anche nel 25% della popolazione generale, non è indicativa di malattia, che deve essere diagnosticata sempre con i test sierologici e le biopsie duodenali.
La dietoterapia
Ad oggi, l’unica terapia disponibile per la Malattia celiaca consiste nell’adozione di una dieta senza glutine per tutta la vita. È indispensabile che, seguendo tale dieta, si presti attenzione alle contaminazioni, in quanto il glutine può essere presente in tracce in cibi naturalmente privi di glutine a causa dei trattamenti industriali dovuti all’addizione di gelificanti o conservanti. L’ultimo “Codex Alimentarius” (2008) fornisce una soglia di sicurezza di 20 parti per milione nei prodotti senza glutine, dose che non dovrebbe causare danno alla mucosa intestinale. Date le difficoltà nella comprensione e nell’aderenza alla dieta, i Pazienti dovrebbero comunque essere valutati da un Dietista/Nutrizionista esperto in dieta senza glutine.
La dieta senza glutine porta alla riduzione o anche all’eliminazione dei sintomi nella maggioranza dei casi, ma può non essere effettiva nei casi di Celiachia refrattaria. I Pazienti celiaci dovrebbero essere monitorati regolarmente per valutare eventuali nuovi sintomi. I marker sierologici sono utili nel follow up del Paziente in quanto possono fornire informazioni utili sulla corretta aderenza alla dieta senza glutine o sulla presenza di contaminazioni dietetiche. Inoltre sono raccomandate ulteriori analisi di laboratorio, incluse la funzionalità epatica e della tiroide.
Trattamenti medici, quali prospettive?
Vi è un forte interesse riguardo alle future possibili disponibilità di trattamenti medici per la Malattia celiaca che potrebbero rappresentare un’alternativa alla dieta senza glutine. Negli ultimi anni, la ricerca si è attivamente focalizzata su potenziali target e sullo sviluppo di farmaci per trattare la Malattia celiaca. Il miglioramento della degradazione del glutine, allo scopo di ridurre la sua immunotossicità, potrebbe essere raggiunto con la somministrazione orale di proteasi. Le alternative potrebbero essere lo sviluppo di varietà non immunogenetiche di glutine o di probiotici capaci di detossificare il glutine. La ricerca si è anche focalizzata sulla riduzione dell’esposizione ai peptidi gliadinici “tossici”: è il caso degli inibitori della zonulina, i quali sono stati specificatamente testati per la loro capacità di proteggere la permeabilità intestinale e ridurre il passaggio dei peptidi tossici a livello della matrice sub-cellulare.
Nonostante tutte queste ricerche abbiano dato risultati interessanti, esse sono ancora lontane dallo sviluppo di vere alternative terapeutiche. Una forte raccomandazione per i Pazienti celiaci è quindi ancora oggi quella di attenersi sempre attentamente alla dieta priva di glutine.